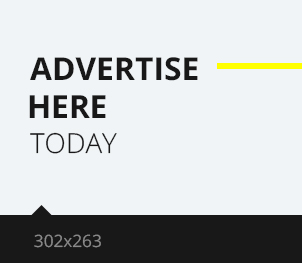Un po’ di qua, un po’ di là: la politica estera “del pendolo” italiana non muore mai e la riviviamo oggi: siamo occidentali, siamo europei – lo siamo ancora? – siamo dalla parte degli Stati Uniti e sotto la loro grande sfera egemonica. Ma questo non ci impedisce di strizzare l’occhio alla “nuova” potenza emergente sullo scacchiere internazionale: la Cina.
Lo sappiamo, i cinesi ci amano, adorano tutto ciò che è made in Italy e non vedono l’ora di scattare foto a qualsiasi cosa faccia parte del nostro bel Paese. Ma noi, cosa ci guadagniamo dall’avvicinamento alla sfera d’influenza cinese? Sembrerebbe molto, stando a quello che afferma il governo in carica: i cinesi sono pronti a investire nelle nostre infrastrutture, a dirigere i flussi di turisti verso lo Stivale e ad aprire sempre più le loro porte all’export italiano (non solo alle arance).
Ma è tutto oro quello che luccica? Molti studiosi vedono la Cina come qualsiasi altra superpotenza in ascesa, la quale sta cercando di trasformare l’unipolarismo del sistema internazionale attraverso la Nuova Via della Seta: porti strategici, “trappole” del debito e finanziamenti offerti a condizioni generose in cambio di concessioni politiche e diplomatiche.
Altri, invece, vedono con favore l’avvicinamento al Dragone asiatico, un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Ma l’Italia ci guadagnerebbe davvero a diventare il cavallo di Troia del Sol levante in Europa?
La Cina non è l’America, forse
Per quei teorici realisti che, come me, vedono lo scenario politico-economico internazionale come un mero gioco di potere fra superpotenze, quello che sta accadendo non è di certo una novità. Il confronto tra una potenza egemone e un’altra in ascesa potenzialmente in grado di minacciarne la supremazia è avvenuto in tanti casi storici: tra Gran Bretagna e Germania a cavallo dei secoli XIX e XX, tra Stati Uniti e Russia nel XX secolo, e così via.
Attualmente, possiamo assistere al confronto USA-Cina, che non si gioca più sulla supremazia militare, ma principalmente su quella economica e tecnologica. E vai allora con guerre commerciali, minacce più o meno velate agli Stati che prendono una posizione diversa, compagnie tecnologiche bannate e accusate di spionaggio (vedi Huawei) e chi più ne ha più ne metta. Niente di nuovo sotto il sole comunque. Ora è solo il turno della Cina.
Un po’ come fecero gli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale – con le dovute differenze – il Dragone asiatico sta cercando di ampliare la sua influenza politica ed economica, camuffando i propri intenti sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli e trasferimento di know-how (qualcosa di già visto in America Latina).
La Cina ha finanziato 80 Stati nel mondo, tutti Paesi in difficoltà economica, ma in ottime posizioni geografiche sullo scacchiere internazionale. Cosa chiede in cambio? Be’, non chiede come gli USA una deregolamentazione dei mercati finanziari e la privatizzazione delle compagnie pubbliche più importanti. Chiede invece porti, chiede che siano le proprie imprese e i propri lavoratori a costruire le infrastrutture e, chi lo sa, “magari” chiede anche un appoggio politico-diplomatico in caso di contenziosi con il mondo occidentale. Insomma, gli attori cambiano, ma la storia si ripete.
Trappola del debito o prezioso aiuto? The Empire strikes back
Secondo una ricerca del Global Development Policy Center della Boston University, la China Development Bank e la Export-Import Bank of China forniscono ora ai Paesi in via di sviluppo finanziamenti pari a quelli della Banca Mondiale. Questi Paesi hanno preferito i prestiti della Cina perché quest’ultima ha finanziato ciò che questi Paesi volevano – ossia grandi progetti infrastrutturali ed energetici senza né vincoli né regole– e non ciò di cui l’Occidente dice che hanno bisogno.
Sono stati però sollevati ragionevoli interrogativi sui prestiti concessi dal Dragone. Come quelli delle banche di sviluppo sostenute dall’Occidente negli anni precedenti, i prestiti cinesi si trovano oggi ad affrontare il default di Paesi che sono stati a lungo definiti “serial defaulters” e non è chiaro se i cinesi saranno rimborsati per intero.
Il grafico mostra il rapporto debito/PIL in % dei Paesi aderenti alla Via della Seta nel corso degli anni (per una visualizzazione ottimale del grafico da mobile, ruotare lo schermo in orizzontale)
I primi otto Paesi che hanno aderito alla Via della Seta hanno nettamente peggiorato il loro indebitamento in soli due anni, per via degli interessi applicati sul prestito, delle scadenze non onorate e degli impegni che Pechino ha deciso di intraprendere nei loro Paesi. In Laos il rapporto debito/PIL è così passato dal 50 al 70%, nelle Maldive dal 39 al 75%, a Gibuti dall’80 al 95% e in Pakistan dal 12 al 48%.
Ma il debito non sembra essere un grande problema per il Dragone, che è sempre pronto a rinegoziarlo, a cancellarne una parte1 o a richiedere in cambio il controllo totale di ciò che hanno costruito2, soprattutto se questi Paesi hanno accesso anche ad altri finanziamenti provenienti dal mondo occidentale.
Non è una trappola, è solo il perseguimento di un sogno, il cosiddetto “sogno cinese”, ovvero rendere l’Impero protagonista dell’ordine internazionale entro il 2049, un anno dall’alto valore simbolico perché segnerà il centenario della proclamazione della Repubblica Popolare. Entro quell’anno, il presidente cinese Xi Jinping vuole riscattare il Paese dalle vergogne del cosiddetto “secolo dell’umiliazione”3.
Poi il pericolo di un “credit boom”, che può innescare una nuova crisi finanziaria globale, è un’altra storia. Anche se il rischio è più che reale.
Come si posiziona l’Italia in tutto questo?
Noi ci posizioniamo un po’ di qua e un po’ di là. E come sempre ci isoliamo dal resto del mondo. Non una grande mossa, che ci ha sempre portato a non avere nessuna voce in capitolo tra i nostri alleati e storicamente a perdere più che a vincere. Gli Stati Uniti, dopo la firma del memorandum d’Intesa4 con la Cina, hanno paura che l’Italia sia l’anello più debole del sistema europeo e in particolare del G7 e che questo anello finisca col diventare un cavallo di troia dei cinesi, permettendo loro di entrare nell’area di influenza USA.
Nessuno pensa che l’Italia non debba concludere accordi commerciali con la Cina: si pensa solo che, come la Francia, tutto questo si potesse fare a livello europeo e non da soli. Certo, non ci tratteranno da Paese in via di sviluppo, ma, come successo con la Grecia – il cui ministro degli esteri bloccò il raggiungimento dell’accordo promosso dall’Unione Europea all’ONU sulla condanna della pena capitale – ci chiederà almeno “protezione diplomatica”, anche sui temi cardine del mondo occidentale come i diritti umani, che abbiamo conquistato a fatica.
Scommettere sulla Cina è per l’attuale leadership italiana un modo per dimostrare l’indipendenza del Paese dall’UE, per dire insomma che l’Italia non dipende dalle sue sovvenzioni. Si tratta di una scelta politica paradossale, dato che siamo geograficamente ed economicamente immersi in Occidente e più o meno nel lungo termine gli investimenti cinesi si manifesteranno nella dipendenza dell’economia italiana da Pechino. E poi, chi glielo spiegherà ai nostri alleati?
Ci conviene veramente a livello economico?
Come già accennato, non è una cosa negativa concludere accordi commerciali con la Cina, anzi. Considerando la difficoltà delle aziende italiane a entrare nel mercato cinese, cercare qualche via privilegiata per aumentare le esportazioni verso Est non può che farci bene.
Il problema è: possiamo veramente negoziare con la Cina? Molto improbabile, visto che da soli contro Pechino non siamo niente, e il Dragone benefattore vorrà qualcosa in cambio a un certo punto. Sono i dati a ricordarcelo: nel 2018 abbiamo esportato verso la Cina merci per 13 miliardi di euro, a fronte di un import del valore di 30 miliardi, la nostra bilancia commerciale è in perenne disavanzo e anche la nostra quota in Cina è appena dell’1%, nonostante i molti programmi di penetrazione commerciale. Come si vede nel grafico, sono gli Stati Uniti (e Paesi europei come Francia e Germania) i nostri principali partner commerciali, con gli USA abbiamo addirittura un saldo commerciale positivo.
Inoltre, avevamo veramente bisogno dei finanziamenti cinesi per l’ammodernamento del porto di Trieste, del porto di Genova e chissà cos’altro? No, perché l’Italia avrebbe a disposizione 20 miliardi di euro di finanziamenti europei per il periodo 2014-2020 da spendere solo in infrastrutture. Abbiamo appena chiuso il quarto anno e ne abbiamo spesi solo il 5%. Quindi non è la ricerca di capitali che ci guida: piuttosto, l’ansia di “liberarci del giogo di Bruxelles”. Cui prodest? Ma soprattutto: avremo la possibilità, stavolta, di fare marcia indietro quando ci accorgeremo di aver fatto il passo più lungo della gamba?
1 – Ne è un esempio Cuba, per la quale la Cina nel 2010 ha cancellato 2,8 miliardi di dollari di debiti o l’Etiopia a cui Pechino ha perdonato gli interessi dovuti per i prestiti concessi negli anni precedenti.
2 – In Sri Lanka, dove il governo ha deciso di cedere nel 2016 il controllo del porto di Hambantota ad una società statale cinese per evitare di non onorare i debiti.
3 – Quando nel 1839, Il Regno Unito, che all’epoca era senza dubbio la potenza egemone nel mondo, ha costretto l’impero celeste ad aprire le sue frontiere scrivendo definitivamente la parola fine sull’isolamento internazionale in cui la Cina si era barricata prima e durante la dinastia Qing.
4 – Panda Bond: l’obbligazionario “made in China”