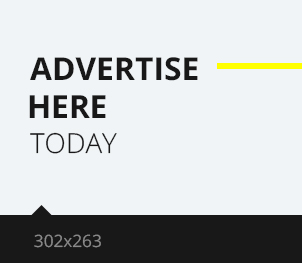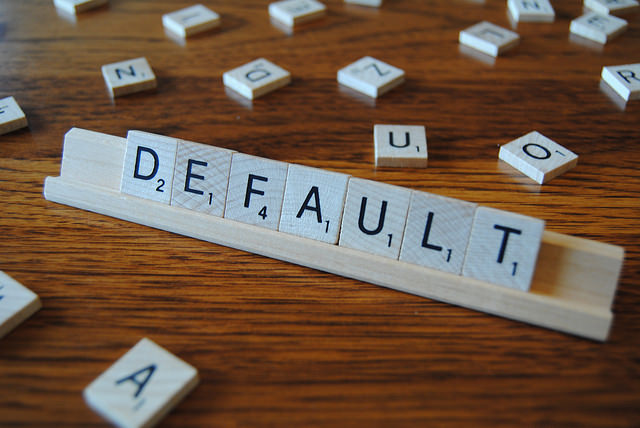Nell’estate 2015 la Grecia ha sfiorato il default, scongiurato in extremis dall’accordo con l’Eurogruppo del 13 luglio 2015 e da una ristrutturazione preventiva, con il supporto di BCE, UE e prevedibilmente FMI.
Ora si teme per le sorti dell’Ucraina, che il 27 agosto 2015 ha raggiunto un accordo per la ristrutturazione del debito, dal quale la Russia si è però chiamata fuori. A Kiev restano quindi da pagare 3 miliardi di dollari in titoli di Stato da rimborsare alla Russia, pena il default. Ma cosa significa “fare default”? Quali sono le conseguenze economico-giuridiche?
Cosa vuol dire fare default?
Quando uno Stato non riesce più a ripagare i suoi debiti, spesso contratti con finanziatori esteri, dichiara default. Con tale dichiarazione, si avviano negoziazioni per la ristrutturazione del debito fra il paese debitore e i finanziatori (che si riuniscono in un comitato), assistiti dai rispettivi consulenti. Con il default, il paese non ha più accesso ai mercati finanziari per raccogliere nuovo debito (almeno sino alla definizione della ristrutturazione) né ai prestiti del Fondo Monetario Internazionale (FMI).
La ristrutturazione è il procedimento con cui il debito viene modificato (attraverso swap) nelle sue condizioni essenziali:
- riduzione del suo ammontare, attraverso la rinuncia parziale, spesso sostanziale, al credito da parte dei finanziatori;
- maggiore durata residua del debito, spesso portata a lunghissima scadenza (e.g. 20-30 anni);
- riduzione degli interessi applicati.
Default sul debito domestico e sul debito estero
Mentre il default sul debito domestico (sottoscritto dai cittadini dello stato) è regolato dalla legge locale, il debito estero è regolato in modi difformi, portando a casi di default sempre complessi.
Alcuni esempi del passato: negli anni Ottanta il debito estero di molti paesi latino-americani fu ristrutturato (con perdite in conto capitale del 30-50% sul valore nominale) e convertito in debito a lunghissimo termine denominato in dollari e garantito dal governo USA (i famosi Brady bond). L’Argentina è andata in default 3 volte dal 1980 (cui si aggiunge il default tecnico del luglio 2014), e nei 215 anni a far tempo dal 1800 è stata in default per ben 80 anni complessivi.
Il Venezuela ha il record (che potrebbe presto battere) di 11 casi di default dal 1800.
Ogni storia è diversa, ma con alcuni punti in comune:
- il sacrificio richiesto agli investitori;
- lo swap fra vecchio debito e nuovo debito ristrutturato, a valori nominali inferiori;
- l’apertura di contenziosi legali fra Stato, investitori, banche.
Lo scenario diviene più complesso quando investitori professionali specializzati in default, come i “fondi avvoltoio”, entrano in scena acquistando partite di vecchi bond che non sono stati consegnati in sede di swap dai vecchi possessori; questi acquisti avvengono a valori scontati (il vecchio debitore cerca di incassare “pochi, maledetti e subito”), con l’obiettivo di avviare negoziazioni per vedersi riconoscere dal debitore un valore il più alto possibile, sia tramite accordi diretti che azioni legali.
La battaglia legale sui bond argentini
Il contenzioso legale è la conseguenza della diversa legislazione che regola le vecchie emissioni di debito andate in default. Ad esempio, l’Argentina ha emesso, in passato, una pluralità di debito pubblico regolato dalle leggi argentina, statunitense, inglese, avendo come controparti (investitori) soggetti diversi che hanno sottoscritto contratti con condizioni contrattuali diverse (interessi, durata, clausole di risoluzione anticipata per mancati pagamenti sul debito, o su altri debiti: la c.d. clausola cross default): per ogni emissione vi sono quindi contratti diversi, e se non si raggiunge un accordo complessivo (che nel caso argentino non si è raggiunto), i singoli investitori hanno la possibilità di agire legalmente per difendere i propri diritti di finanziatori. Questo si è puntualmente verificato con riferimento ai bond che non sono stati convertiti in sede di swap del 2005 e del 2010, bond regolati da leggi USA ed inglese, e che sono stati successivamente acquistati da fondi specializzati.
Questi vecchi bond hanno speciali clausole, come la RUFO, che prevede che un eventuale accordo separato fra Argentina e detentori di titoli originali ante-default smonti la struttura complessiva della ristrutturazione del debito argentino, col risultato che capitale ed interessi – stimati in oltre $30 miliardi – diventerebbero immediatamente dovuti ed esigibili. Seppure la clausola RUFO sia venuta a scadere lo scorso dicembre 2014, ad oggi non c’è stato accordo fra le parti. Non solo, nel 2014 l’Argentina ha sostituito il trustee (che era una banca USA) come agente pagatore con una banca locale argentina, presso la quale ha depositato $161 milioni, disponibili per il pagamento agli obbligazionisti che hanno in mano i bond emessi post-ristrutturazione del debito nel 2005 e nel 2010, a condizione che gli investitori trasferissero i titoli al nuovo trustee argentino.
Da qui è nata una disputa legale, ancora in corso, avviata presso la Corte USA, il cui giudice ha a suo tempo ritenuto illegale la decisione con cui la legge argentina ha consentito di trasferire la giurisdizione dei bond fuori degli USA (dove i bond erano stati contrattualizzati). Lo stesso giudice USA ha sancito che per poter passare ad incassare, gli obbligazionisti internazionali che non abbiano trasferito la giurisdizione dei loro bond in Argentina dovranno chiedere l’autorizzazione del giudice USA; senza tale autorizzazione, diverrebbero complici dell’Argentina, poiché consentirebbero al governo di eludere la sentenza del giudice USA.
La matassa legale, come si vede, è molto complessa, sia in questo caso che in tutti i casi ove vi siano emissioni di bond regolati da leggi straniere, e spesso di diversi paesi, con previsioni di arbitrati regolati da giurisdizioni internazionali.