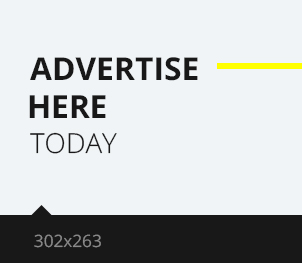“ Qui devi correre più che puoi per restare nello stesso posto. Se vuoi andare da qualche parte, devi correre almeno il doppio.”
Lewis Carrol “Alice nel paese delle meraviglie”
Qualche giorno fa sono incappata in un bel post di Alfonso Fuggetta su Medium che, con la consueta lucidità, si interrogava su come sia possibile fare davvero innovazione in Italia.
Ho trovato condivisibili le argomentazioni esposte, e anche l’elenco di soluzioni proposte. Alla fine della lettura, però, sono stata colta da un certo sconforto perché in fondo ritengo che, nonostante tutte le possibili misure già intraprese e da intraprendere per creare un ecosistema per l’innovazione, sarà difficile rendere l’Italia un paese davvero innovativo in assenza di un reale shock culturale.
Le classifiche ufficiali che misurano il grado di innovazione, a prescindere dalle diverse metodologie adottate, non ci attribuiscono mai una posizione lusinghiera. Secondo il Global Innovation Index, appena pubblicato, ci collochiamo al 31esimo posto, tra il Portogallo e la Malesia, obiettivamente parecchio malmessi, tra i paesi più ricchi e industrializzati.
In Italia oggi, parlare di innovazione è all’ordine del giorno, e bisogna ammettere che qualcosa a a livello di sistema è anche stato fatto. Si pensi ad esempio al programma di misure che a partire dal 2012 sono state messe in campo dal Governo per le startup innovative, un programma obiettivamente ben articolato.
Ma sono state azioni davvero efficaci? Avranno un reale impatto? Se si considerano le 4.704 startup innovative registrate al terzo trimestre del 2015, verrebbe da pensare di sì.
Un conto è avere una buona idea, impostare un piano per realizzarla e spendere poche migliaia di euro per creare una startup attorno a questi elementi. Tutt’altra cosa è fare di una startup una vera impresa che generi ricchezza, lavoro e crescita per il paese.
Per questa transizione, che peraltro non accade spesso, servono finanziamenti, non tanto pubblici quanto dal sistema privato, che vede nei fondi di Venture Capital lo strumento principe per il finanziamento delle startup.
Ma quanto grande è il settore del Venture Capital in Italia?
Dire che l’investimento del settore del Venture Capital in Italia è pari allo 0,002% del PIL è abbastanza deprimente ma, senza nessun pregiudizio, vederci collocati tra Bulgaria e Ucraina, lo è ancora di più.
Per chi non è già troppo sconfortato, invito a leggere un lavoro recentissimo e ricco di dati presentato dal professor Carlo Mammola a fine settembre, intitolato “Finanziare l’innovazione in Italia”. La conclusione è che l’accesso al funding tramite il Venture Capital, cioè “la benzina” delle startup, non solo ha una dimensione risibile rispetto ai maggiori paesi, ma sostanzialmente non accenna a crescere.
E quindi?
Non è che, come correttamente diceva Fuggetta, in Italia non si faccia nulla, ma si intraprendono iniziative perlopiù “di facciata”, come illustrato nella slide, che riporto dalla presentazione sopracitata.
Ogni giorno si svolgono convegni, hackathons e competizioni per startup (52 nel 2014!!) che spesso forniscono premi talmente scarni che non bastano a coprire l’affitto annuale di un ufficio non troppo grande a Milano.
Abbiamo ben 48 (!) piattaforme di crowdfunding, 100 tra incubatori e acceleratori, e addirittura 46 Fablabs che non so bene cosa siano, ma fanno tanto “Alice nel paese delle Meraviglie”.
Perché non si riesce ad innovare in Italia?
Di fatto le iniziative prese per promuovere l’innovazione in Italia restano “lettera morta” e appannaggio di piccolo gruppi di addetti ai lavori, che spesso non hanno mai investito un euro dei propri quattrini in un’impresa innovativa, ma si sentono stracool a blaterare di “ecosistemi digitali”.
Mancanza di una cultura dell’investimento di rischio
In questo paese non esiste una vera cultura dell’assunzione di rischio, elemento imprescindibile dell’investimento. Anzi, come ripetiamo sempre ai nostri clienti di AdviseOnly, il rischio è parte dell’atto stesso di investire. L’assunzione di rischio richiede metodo e capacità di misurare il rischio stesso, nonché il valore e le prospettive di un’azienda. In Italia dominano le relazioni, non le valutazioni di merito, la prassi generalizzata di finanziare “gli amici” in assenza di appropriati strumenti di rating, ha determinato un vero e proprio boom delle sofferenze bancarie.
Come investono gli italiani?
Gli Italiani preferiscono la rendita, non investono in quote di aziende, cioè in azioni, sono abituati da sempre a investire come cassettisti in titoli di stato o in buoni postali, oggi spesso a rendimenti negativi. Mal che vada, c’è sempre il caro vecchio mattone. In Italia il 60% della ricchezza delle famiglie è collocata in attività reali.
Del 40% rappresentato dalle attività finanziarie, il 31% è composto da contante, depositi e risparmio postale e solo un misero 18% è investito in azioni (fonte Banca d’Italia “La Ricchezza delle famiglie italiane 2014”). Tanto per avere un termine di paragone, negli USA la quota diretta e indiretta di investimenti nel mercato azionario è vicina al 50%.
La paura del cambiamento
L’Italia è un paese dominato dalla paura, non si prendono rischi, si scommette su quanto è sicuro, spesso in maniera furbesca, o attraverso i già citati meccanismi relazionali della cerchia di “amici”.
Gli innovatori nel nostro paese non si sentono supportati dal sistema o dall’approvazione comune, sono “isolati” in un mondo che cerca di perpetrare se stesso e i propri privilegi su cui vari gruppi e gruppetti corporativi sono arroccati. È qualcosa che riscontro ogni giorno nel mio ambito professionale, che è quello finanziario.
Le banche faticano ad abbracciare il cambiamento tecnologico ormai in atto su scala globale, non tanto perché non lo capiscano, quanto perché la trasparenza legata alla “digitalizzazione” del risparmio e degli investimenti riduce le asimmetrie informative tipiche della finanza, sulle quali le banche stesse hanno costruito il proprio potere e i propri guadagni.
Fallire in Italia è un po’ morire
In Italia il fallimento è considerato un marchio sociale, il costo economico medio relativo a un fallimento è circa il doppio che negli altri paesi del G20. I tribunali fallimentari di Milano sono affollati di fallitori-seriali, personaggi ai margini della legalità che non hanno più nulla da perdere. Un lavoro di Ernst & Young del 2013 su come spingere l’imprenditoria in Italia, riporta che tra gli imprenditori uno su 10 considera il fallimento un’opportunità per imparare, il 36% lo considera un fallimento in carriera e il 42% una barriera per possibili progetti futuri.
Negli USA e in altri paesi avanzati, esistono schiere di cosiddetti “imprenditori seriali” che parlano dei propri fallimenti con serenità, quasi con orgoglio, se dopo si sono rialzati per affrontare più forti una nuova avventura.
Dove sono le IPO?
La capitalizzazione della Borsa Italiana rispetto al Pil è davvero ridotta, si attesta oggi sotto il 30%, contro il 42% della Germania, il 68% della Francia, il 73% della Spagna il 115% dello UK.
Sappiamo che il taglio medio dell’azienda italiana è piccolo, le imprese sono familiari, gli imprenditori domestici hanno l’ossessione del controllo. L’accesso alla Borsa non viene visto come un’opportunità per cambiare passo e internazionalizzarsi, quanto piuttosto come la scelta opportunistica di chi ragiona in termini di “prendi i soldi e scappa”.
In Borsa vanno a ruba solo le scelte sicure, come appunto le Poste Italiane, fresche di quotazione.
Come si crea una cultura per l’innovazione?
Ulteriori iniziative da parte dello Stato, come ad esempio un maggiore supporto finanziario diretto alle startup o all’innovazione, avrebbero probabilmente effetti distorsivi, portando con sé problematiche di scarsa efficienza e opacità.
Ci vuole tempo per creare una vera cultura dell’innovazione, che è qualcosa di molto diverso ma intimamente legato ad un “ecosistema dell’innovazione”. Mi vengono in mente due strumenti principali per influire sulla cultura: le scuole e i media.
- Le scuole, dove crescono gli innovatori di domani, dovrebbero avvicinarsi maggiormente alla realtà attuale a riportare in auge una cultura del creare, più che del mero sapere.
- I media potrebbero raccontare storie di innovazione e celebrare gli aspetti positivi dell’imprenditoria italiana o presentare aspetti virtuosi di iniziative in altri paesi (la BBC lo fa da sempre). Iniziative come quella di sostegno alle startup meriterebbero di venir comunicate e spiegate adeguatamente.
Purtroppo la nostra tv, su questi temi, non è riuscita a darci di meglio di “the Apprentice”, reality pensato e condotto da Flavio Briatore o il recente “Shark Tank”, un format di reality importato dagli USA dove lo “startupparo de’ noartri” deve convincere i potenziali finanziatori a investire nel suo progetto. Non credo sia abbastanza.