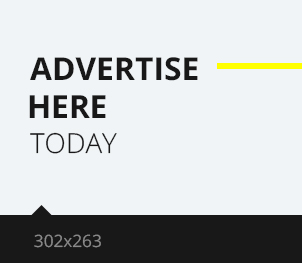Negli ultimi anni, la sensibilità verso le tematiche ambientali è decisamente cresciuta a livello globale, tanto che, ad oggi, il cambiamento climatico è tra le minacce più temute al mondo e sempre più spesso i criteri ESG (cioè di responsabilità ambientale, sociale e di governance) contribuiscono a orientare le scelte dei consumatori. Secondo un rapporto della Camera Nazionale della Moda Italiana, sviluppato con McKinsey & Company e focalizzato sui department store di tutto il mondo (“Global Sustainability Report: sustainability matters, but does it sell?”), circa il 70% dei consumatori preferisce scegliere un prodotto a ridotto impatto ambientale rispetto a uno non ecosostenibile, anche se il prezzo è maggiore del 5-10% rispetto alla media dello stesso prodotto non etichettato come “eco-friendly”.
Le aziende se ne sono rese conto e hanno colto la palla al balzo, non sempre in modo del tutto trasparente. In alcuni casi, infatti, invece di lavorare seriamente sulla riduzione del proprio impatto ambientale, certe imprese, organizzazioni e/o istituzioni si sono limitate a darsi “una verniciata di verde”, costruendo una strategia di comunicazione volta a dare un’immagine di sé ingannevolmente “green”. Questo fenomeno ha raggiunto dimensioni tali da meritarsi una definizione ad hoc: “greenwashing”.
In che cosa consiste il greenwashing?
Le pratiche di greenwashing più utilizzate sono molto semplici: uso di marchi con il suffisso “eco”, utilizzo del verde come colore dominante, assegnazione dell’etichetta “eco-friendly” al prodotto. Uno dei casi più eclatanti di greenwashing risale agli anni Ottanta, quando l’azienda petrolifera Chevron investì grandi risorse in una serie di spot televisivi volti proprio a enfatizzare la sua sensibilità all’ambiente e alla biodiversità, una strategia palesemente volta a distogliere l’attenzione pubblica dalle sue pratiche inquinanti. Ma non mancano gli esempi più recenti. Solo negli ultimi mesi, infatti, sono finite nel mirino della britannica Advertising Standards Authority per pratiche di greenwashing la compagnia aerea irlandese Ryanair, la casa automobilistica tedesca BMW e la società energetica olandese Shell.
A questa pratica non è estraneo nemmeno il settore finanziario – non che sia la regola, ma capita: in questo ambito, il greenwashing si può nascondere per esempio dietro l’enfasi comunicativa posta sull’unico progetto ecosostenibile finanziato, magari mentre la stessa società foraggia altre attività tutt’altro che “green”, o ancora dietro partnership con organizzazioni non governative siglate allo scopo di “utilizzare” il brand e la buona reputazione altrui.
Come riconoscere il greenwashing?
La prima cosa da fare, come sempre, è informarsi: guardare l’azienda nel suo complesso e cercare informazioni sulle sue politiche di business e sostenibilità ambientale e su come esse vengono applicate lungo tutta la filiera produttiva.
La buona notizia comunque è che già da qualche tempo le autorità di regolamentazione si stanno mobilitando per limitare il fenomeno. “È importante che le autorità pubbliche intervengano e stabiliscano standard solidi” per l’ESG e “monitorino gli attori e prodotti rilevanti per prevenire i rischi di greenwashing”, ha dichiarato tempo fa il presidente dell’ESMA Steven Maijoor in un discorso allo European Financial Forum di Dublino.
Parlando nello specifico di investimenti sostenibili, Maijoor ha criticato i rating di sostenibilità per “l’assenza di trasparenza nel loro calcolo e la loro diversità” che “non aiutano gli investitori a confrontare efficacemente gli investimenti etichettati come sostenibili”. Intanto a fine 2019 il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno trovato un accordo sulla “tassonomia green”, per definire in modo più chiaro le attività di investimento che possono essere classificate in conformità con i criteri ESG.
E in Italia come siamo messi?
In Italia a occuparsi di greenwashing è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – si tratta infatti, in buona sostanza, di casi di pubblicità ingannevole. Una delle prime pronunce di condanna relative al greenwashing nel nostro Paese ha riguardato Snam, per il suo slogan “il metano è natura” nel 1996. Ci sono state poi altre sentenze, come quelle contro l’acqua minerale San Benedetto e Ferrarelle, o contro la Coca Cola.
Il 27 marzo 2014, poi, è entrato in vigore un nuovo articolo del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (“Tutela ambientale”) che frena il greenwashing e controlla i “green claim”, ovvero i messaggi pubblicitari che contengono rivendicazioni ambientali. Ma, naturalmente, siamo solo all’alba di una battaglia culturale impegnativa, nella quale saremo sempre di più chiamati a prendere una posizione forte e chiara. Come consumatori, ma anche come investitori.