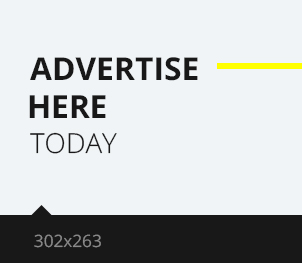Molti investitori ritengono che le banche non siano buoni investimenti, perché i loro business sono troppo complessi (black box) o perché non c’è un sufficiente margine di sicurezza data l’inerente leva utilizzata[1].
Per le banche italiane, la tesi a favore è semplice:
- dopo la crisi del 2008 hanno stabilizzato la loro struttura patrimoniale ritornando a rapporti Core Tier I tra i più elevati in Europa;
- il nostro settore privato (aziende e famiglie) non è iper-indebitato come in altre nazioni;
- il mercato immobiliare non ha vissuto bolle;
- le valutazioni sembrano a buon mercato, soprattutto quando misurate dal Price/Book Value, rispetto ai competitors europei
- l’economia, seppur lentamente, mostra segni di una leggera ripresa e le banche saranno le prime a beneficiarne (si sente spesso dire che le banche sono “una scommessa a leva sull’andamento macroeconomico”)
La tesi opposta, che personalmente condivido, è invece che le banche italiane non siano sufficientemente redditizie e pertanto non creano nessun valore per gli azionisti nel lungo periodo. Occorre, a questo punto, una necessaria premessa sulle regole di Basilea.
Basilea 2 e 3: cosa c’è di sbagliato
Il capitale delle banche è stato negli ultimi anni un acceso argomento di dibattito, con opinioni da parte di accademici, autorità di mercato, banche, media e naturalmente politici. Il problema è che questa discussione è stata incentrata sui modelli matematici alla base delle regole di Basilea 2 e 3, facendo perdere di vista il reale significato di capitale.
Il concetto è in realtà molto semplice: il capitale delle banche serve a proteggere da perdite inattese. Dovrebbe essere usato per difendersi da problemi non previsti, mentre le perdite attese sono spesate ogni anno nel conto economico sotto forma di rettifiche di valore per deterioramento degli impieghi (loan loss provisions).
Il ruolo del capitale è di rassicurare i creditori, inclusi i depositanti e, in ultima istanza, le autorità: trovare il suo livello appropriato è una decisione chiave per la stabilità e longevità di ogni banca.
Purtroppo le regole di Basilea sono fuorvianti. L’idea di ponderare le attività secondo il loro presunto grado di rischio (la metodologia di risk-weighted assets, RWA) è sbagliata da un punto di vista fondamentale ed è stata in gran parte responsabile delle crisi degli ultimi anni. Questo perché gli impieghi sono pesati a seconda del loro rischio atteso, ma le passività non lo sono: anche se un prestito di €100 può avere un peso di 0% o 50% (e quindi contare “meno” in termini di RWA), richiede sempre €100 di passività (depositi, debito o mezzi propri) per supportarlo.
A riprova di quanto detto, basta vedere i risultati dei primi stress test fatti dalla European Banking Authority (EBA) nel luglio 2011: tre banche che avevano ottenuto il via libera (Dexia, SNS Bank e Bank of Cyprus) sono poi fallite, mentre la spagnola Bankia, per la quale si prevedeva un deficit massimo di €1,3 miliardi nel caso peggiore, ha invece avuto bisogno di €24 miliardi di nuovi fondi.
Senza contare tutte quelle banche che hanno superato gli stress test ma poi hanno dovuto procedere a una ricapitalizzazione attraverso la vendita di assets, il taglio dei dividendi o aumenti di capitale. Focalizzarsi su RWA e Core Tier I ratio ha molti difetti, mentre un semplice screening su equity-to-assets ratio porta, al contrario, a risultati migliori: le tre banche che avevano ottenuto luce verde dalla EBA, ma sono poi fallite, avevano infatti un ratio di appena l’1%!
Anche sotto questa metrica, le banche italiane sono oggi tra le più “solide”: con l’eccezione di MPS pre-aumento di capitale, tale rapporto è generalmente tra 4,5% e 6,5% (che corrisponde ad una leva di 15x-22x). Purtroppo, questo non basta: una bassa leva finanziaria non è stata una garanzia sufficiente nel corso della recente crisi.
Alcune delle banche che ne sono uscite meglio (quelle scandinave, ad esempio) avevano infatti equity/assets ratio tra i più bassi in Europa; al contrario, molte di quelle che hanno sofferto di più avevano una leva tutto sommato contenuta. La differenza principale è che le prime sono rimaste redditizie durante tutto il periodo, mentre le seconde no.
Le considerazioni sul capitale non possono essere scisse dalla redditività, perché è soprattutto la qualità degli impieghi che determina le fortune di una banca. Anche se questa è sufficientemente solida, quello che alla fine conta per gli investitori è se genererà sufficienti profitti rispetto ai mezzi propri/capitale impiegato. Molte banche italiane sono entrate nella crisi con una leva moderata, ma la loro risicata (se non negativa) redditività nel tempo ne ha eroso il capitale.
Una veloce analisi del settore bancario italiano
La prima cosa che si può dire è che in Italia ci sono troppe banche: secondo i dati della Banca Mondiale, nel nostro paese vi è infatti una filiale ogni 1.600 persone (peggio solo la Spagna con una filiale ogni 1.350 persone), numeri di gran lunga superiori rispetto a Francia (2.580), UK (4.500), Olanda (5.750) e Germania (6.800).
Nonostante questo, a riprova di quanto siano radicate nel nostro sistema economico-finanziario (soprattutto per il settore corporate) e di come non ci sia una vera concorrenza, le banche italiane riescono comunque ad avere margini in linea con gli altri paesi.
Nei grafici sottostanti sono riportate due variabili chiave:
- il margine d’interesse netto (net interest margin, NIM), che misura lo spread tra il rendimento degli impieghi e il costo del loro finanziamento;
- il rendimento prima delle rettifiche (pre-provisions return on assets), che indica quanto rendono complessivamente tutti gli attivi.
Come si può vedere, a livello aggregato la situazione italiana non è peggiore di quella di altri paesi europei, anzi è spesso migliore rispetto a un gigante come la Germania.
Nota: i dati si riferiscono alle principali banche quotate, non a tutte quelle operanti in uno specifico paese.
Tuttavia, il parametro chiave per valutare le prospettive future di una banca (nonché quello principale nel determinare a quali multipli può trattare) è il livello normalizzato di ROE (Return on Equity) che questa riesce a generare. E da questo punto di vista, le banche italiane sono molto indietro rispetto ai competitor europei.
Quali sono le cause di questa redditività inferiore? In parte è dovuto proprio al fatto che le banche italiane utilizzano una minore leva: vale infatti la relazione ROE ~ ROA x leva. Quello che penalizza le banche italiane è però soprattutto la struttura dei costi: per le nostre banche, in media il 75% del margine di intermediazione lordo viene consumato dalle spese operative (e di questo, il 42% è il costo per i dipendenti), rispetto al 65% in Francia, 55% in Germania, 48% in Spagna e 62% in UK.
Il secondo grosso problema è quello della qualità del credito: le banche italiane prestano spesso male, non solo per colpa loro. Dal 2002, includendo quindi sia gli anni favorevoli (pre-2007) che quelli di recessione (post-2008), il rapporto medio tra prestiti incagliati lordi e impieghi è stato di 8,5%: su €100 prestati, su un ciclo economico completo, quasi €9 si rivelano in qualche modo problematici, valori che sono di nuovo molto superiori agli altri paesi europei (Francia: 5,7%; Germania 1,7%; Spagna e UK: 3,7%).
I “conti della serva” alle banche italiane
Il core revenue margin[2] dei nostri istituti è stato negli ultimi 15 anni compreso tra 2,5% e 3,5%: dati non sorprendenti viste le considerazioni fatte prima sulla bassa concorrenza nel settore.
Negli ultimi anni è stato più vicino alla parte bassa del range, ma assumiamo che in futuro il livello normalizzato sia attorno a 300 punti base. Almeno il 70% di questo margine è “mangiato” dai costi, lasciando un margine operativo netto inferiore a 100 punti base. A questo vanno poi aggiunte le rettifiche per il deterioramento dei crediti e il pagamento delle tasse: è facile capire perché molte banche continuano a registrare perdite e che su queste basi il ROA normalizzato può essere attorno a 0,40%-0,50%, come è in effetti stato negli ultimi anni per le migliori banche.
Se completiamo questa valutazione con i limiti imposti dalle nuove regole di Basilea 3 (un livello minimo di capitale del 4,5% più un buffer aggiuntivo di 2,5%: il limite di 7% equivale a grandi linee ad una leva inferiore a 15x), vediamo come sotto queste assunzioni – non certo punitive – il ROE futuro potrà essere tra 6% e 7,5%.
Questo valore (che, ripetiamo, poche banche italiane sono in grado di avere al momento) è soprattutto inferiore al costo dei mezzi propri: ne consegue che il settore in aggregato tratta a sconto rispetto al book value (P/BV<1). Ci sono due possibilità: o le banche riducono l’incidenza dei costi (salari, costi operativi e rettifiche sugli impieghi), oppure non creeranno alcun valore per gli azionisti, anzi: continueranno a distruggerlo.
Conclusioni
Purtroppo non esiste una formula quantitativa che aiuti velocemente a valutare una banca: gli aspetti qualitativi da considerare sono molteplici e complessi.
Se dovessi ridurre l’analisi al minimo indispensabile, potrei dire che se proprio volete comprare una banca, cercatene almeno una che sia di qualità, e questa dipende in maniera preponderante dal DNA delle persone che ci lavorano e la gestiscono.
È meglio pagare un po’ di più per una “buona” banca che comprarne una “cattiva” a saldo: investire solo perché il prezzo sembra allettante non è sempre una buona idea, perché spesso gli azionisti vengono diluiti da massicci aumenti di capitale imposti dalle autorità (MPS, Carige). Pagare per qualcosa di qualità è invece la scelta migliore e più sicura nel lungo periodo.
[1] L’analisi di una banca è un esercizio complesso e alquanto tecnico. Per mere ragioni di spazio, molte considerazioni sono state semplificate: le conclusioni, che valgono in aggregato, non sono necessariamente le stesse per ogni singolo istituto finanziario.
[2] Un’estensione del Net Interest Margin (NIM), in quanto include oltre agli interessi netti anche le commissioni nette incassate.
Nota: questo post è pubblicato a scopo puramente informativo e non vuole assolutamente costituire una raccomandazione né di acquisto né di vendita. Le informazioni presentate sono state redatte usando fonti ritenute affidabili, accurate ed in buona fede, e sono riferite alla data di redazione: ogni opinione espressa è passibile di modifica senza preavviso. Ogni lettore è pregato di fare le proprie considerazioni e valutazioni, anche e soprattutto sull’idoneità degli investimenti alle proprie caratteristiche finanziarie. In nessun caso, l’autore non potrà mai e in nessuna forma essere ritenuto responsabile delle conseguenze, dovute anche ad imprecisioni e/o errori, derivanti dall’uso che il lettore, in totale indipendenza ed autonomia, potrà fare delle informazioni presentate.